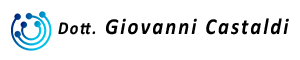La camera chiara. Roland Barthes
 Roland Barthes scrisse questo libro nel 1980 pochi mesi prima di morire. Sono note e riflessioni, considerazioni e digressioni sulla fotografia come si legge nella terza di copertina. Il testo è attraversato da una dimensione autobiografica. Non sono soltanto parole “indifferenti” - scientifiche e teoretiche - sulla fotografia, ma sono parole dettate da una dimensione personale e soggettiva che riguarda i rapporti che tutti noi abbiamo con le immagini fotografiche. Le fotografie evocano in ciascuno di noi sentimenti e disposizioni affettive, amore, rifiuto, seduzione, nostalgia, bellezza, infinita melanconia e milioni di altre cose ancora. Una fotografia rappresenta anche un mondo di cose e di persone che viene di volta in volta rivissuto. Fondamentale è per Barthes immergersi nella rappresentazione fotografica per giungere a cogliere l'essenza più vera della persona fotografata così come lui stesso fa nel rapporto che intrattiene con la fotografia che ritrae sua madre piccola, ancora bambina, in un giardino d'inverno.
Roland Barthes scrisse questo libro nel 1980 pochi mesi prima di morire. Sono note e riflessioni, considerazioni e digressioni sulla fotografia come si legge nella terza di copertina. Il testo è attraversato da una dimensione autobiografica. Non sono soltanto parole “indifferenti” - scientifiche e teoretiche - sulla fotografia, ma sono parole dettate da una dimensione personale e soggettiva che riguarda i rapporti che tutti noi abbiamo con le immagini fotografiche. Le fotografie evocano in ciascuno di noi sentimenti e disposizioni affettive, amore, rifiuto, seduzione, nostalgia, bellezza, infinita melanconia e milioni di altre cose ancora. Una fotografia rappresenta anche un mondo di cose e di persone che viene di volta in volta rivissuto. Fondamentale è per Barthes immergersi nella rappresentazione fotografica per giungere a cogliere l'essenza più vera della persona fotografata così come lui stesso fa nel rapporto che intrattiene con la fotografia che ritrae sua madre piccola, ancora bambina, in un giardino d'inverno.Barthes guardava una serie di fotografie di sua madre senza riuscire però a ritrovarla e a riconoscerla totalmente, ritrovava solo alcune parti di lei ma finalmente guardando una fotografia molto antica di lei la riconobbe. Era piccola, bambina, insieme a suo fratello in un giardino d'inverno.
Che cosa faceva sì che riconoscesse sua madre in quella fotografia e proprio soltanto in quella immagine fotografica? Barthes risponde che è un'espressione del viso della madre che lui definisce di innocenza, a completarla e a renderla assolutamente sua madre. Innocenza nel senso etimologico, non sapere nuocere. Il viso della ma dre affermava un sentimento di dolcezza.
“Vedevo la bontà che aveva formato il suo essere subito fin da pic cola. La sua bontà era appunto fuori gioco era qualcosa che apparteneva a lei,”nonostante il fatto che da piccola la mamma non fosse stata amata e compresa dai suoi genitori. Il lavoro di Barthes sulla fotografia di sua madre è un lavoro di approfondimento interiore, è un percorso all'interno di se stesso attraverso l'evocazione dell'immagine fotografica materna così come nella Recherce di Proust, quando il protagonista mentre si stava accingendo a togliersi le scarpe scorse all'improvviso nella sua memoria il vero volto di sua nonna in cui
“per la prima volta ritrovavo in un ricordo pieno e involontario la realtà viva”La fotografia della madre nel Giardino d'inverno è quindi una fotografia fondamentale esclusivamente per Barthes, non dice nulla ad altri. Egli incontra la vera essenza di sua madre in quell'immagine che coincide con ciò che aveva percepito di questa donna lungo la sua vita.
Barthes al di là dell'aspetto biografico, centrale a mio avviso come significato e come senso esistenziale, costruisce tre funzioni o intenzioni per la fotografia. Lo Spectator, gli spettatori, noi tutti che guardiamo, l'Operator, il fotografo, l'Eidolon, colui o ciò che è fotografato, che potrebbe essere definito lo Spectrum della fotografia. Spectrum perché la sua radice mantiene un rapporto con lo spettacolo e anche con quella cosa che in ogni fotografia emerge, il ritorno del morto.
Vedere se stessi altrimenti che in uno specchio. Storicamente afferma Barthes questo atto è recente. Il ritratto disegnato o dipinto è stato fino alla diffusione della fotografia un bene limitato a pochi, destinato a rappresentare una condizione sociale ed economica. Il ritratto dipinto non è comunque una fotografia per quanto somigliante sia. L'avvento della fotografia, la prima foto è del 1822 di Niepce, ha comportato una radicale trasformazione nell'ambito delle relazioni micro e macro sociali e oggi con le ultime avanzatissime tecnologie e le immagini digitali, che non erano ancora presenti sul mercato dei media al tempo in cui Barthes scrisse il libro, la fotografia è sempre più sovvertitrice di modelli e di convenzioni sociali. Possiamo creare immagini virtuali che non esistono storicamente ma soltanto tecnologicamente.
Ritorniamo al libro. Sarebbe bello e auspicabile dice Barthes una storia degli sguardi. La fotografia è infatti l'avvento di me stesso come altro, un'astuta dissociazione della coscienza d'identità. Verso il 1840 affinché le lastre dei primi ritratti s'impressionassero, bisognava che il soggetto che si faceva fotografare si sottoponesse a lunghe pose sotto una vetrata in pieno sole; diventare oggetto, faceva soffrire come un'operazione chirurgica, fu allora inventato un apparecchio detto appoggia-testa, una sorta di protesi invisibile all'obbiettivo che reggeva e manteneva il corpo nel suo passaggio verso l'immobilità; tale appoggia-testa era lo zoccolo della statua che io stavo per diventare, il busto della mia essenza immaginaria.
La fotografia per Barthes è vicina nella sua origine storica più al teatro che alla pittura e il punto di connessione e di cerniera tra la foto e il teatro è la morte. Spiega Barthes che il teatro nelle sue forme originarie rappresentava gli attori interpretare i morti, truccarsi significava designarsi come corpo vivo e morto al tempo stesso, si aveva il busto imbiancato del teatro totemico, l'uomo dal volto dipinto del teatro cinese, il trucco a base di pasta di riso del Khata Kalì indiano, la maschera del teatro No giapponese. Nella fotografia abbiamo per certi versi la stessa cosa, il medesimo rapporto. Per quanto viva ci si sforzi d'immaginarla la foto è come un teatro primitivo, come un quadro vivente: la raffigurazione della faccia immobile e truccata sotto la quale noi vediamo i morti.
Due temi riguardano l'approccio visivo alla foto: lo studium che è una sorta d'interessamento all'immagine che guardo e il punctum che è nella fotografia quella fatalità che in essa mi punge ma anche mi ferisce e mi ghermisce, che mi tocca.
La fotografia è l'immagine viva di una cosa morta, certifica la presenza della cosa fotografata che in ogni caso è stata lì per essere fotografata. Anche se noi fotografiamo dei cadaveri accertiamo che il cadavere è vivo sia in quanto soggetto/oggetto cadavere e sia perché prima di esserlo sarà stato qualcosa di animato.
La fotografia nasce come un'arte della persona, della sua identità e della sua condizione civile, attesta che ciò che vedo è effettivamente stato - non parliamo evidentemente delle immagini digitali - e attraverso la posa costruisce un'immagine altra dello stesso soggetto/oggetto fotografato.
La fotografia attesta, documenta, testimonia la realtà senza un particolare metodo. Barthes per avvalorare la sua tesi porta come testimonianza il fatto di avere conservato un ritaglio di un giornale dove si mostrava la scena di una vendita di schiavi. C'era un signore, il padrone, con un largo cappello in testa e accanto a lui accasciati una serie di schiavi seminudi, non era un disegno ma una fotografia che testimoniava che quella scena era stata vissuta in un dato tempo, testimoniava un fatto accaduto nella realtà di un'epoca. Lo storico non era più il mediatore, lo schiavismo era presentato senza mediazione, l'evento era definito senza metodo. Insomma la fotografia prova che qualcosa è stato, l'essenza della fotografia è di ratificare ciò che essa ritrae. Non necessariamente delle immagini fotografiche devono comportare nostalgia o ricordo struggente o gioioso del passato, certamente possono farlo facendo rivivere stati emotivi spesso silenziosi in noi perché pericolosi, ma il fondamento della fotografia è quello di documentare. L'importante è che la foto possieda una forza documentativa e che la documentatività della fotografia verta non tanto sull'oggetto quanto sul tempo. Da un punto di vista fenomenologico nella fotografia il potere di autentificazione supera il potere di raffigurazione.
Fotografare un oggetto, una cosa, dice Barthes, è diverso dal fotografare una persona e soprattutto una persona amata. Nel fotografare un panorama noi autentifichiamo la realtà del panorama ma nel caso osserviamo la fotografia di una persona che ci sta a cuore noi vogliamo ritrovare l'essenza di questa persona, ritrovarla in se stessa, ma non è un'impresa facile perché ritrovare una persona in se stessa appartiene all'ambito di una percezione che coglie qualcosa, un tratto, un certo non so che, che si definisce dice Barthes nell'aria che si propaga da un volto e da un’immagine.
Che cos'è l'aria di un viso o di un corpo? L'aria è ciò che il corpo, la figura, l'espressione, l'insieme della persona producono percettivamente nello sguardo degli altri che li osservano. Barthes riprende la sua grande fotografia della madre nel giardino d'inverno e racconta la procedura di osservazione delle fotografie che ritraevano sua madre.
“C'erano delle foto che mi fornivano solo l'identità anagrafica, superficiale, poi altre immagini che fornivano la sua espressione individuale, analogiche, somiglianti, poi infine la fotografia del giardino d'inverno in cui la ritrovavo al di fuori della somiglianza”L'aria è come il supplemento intrattabile dell'identità. Queste foto di mia madre che passavo in rivista erano un po' tutte delle maschere mentre nell'ultima foto la maschera scompariva, restava un'anima senza età ma non al di fuori del tempo dal momento che quell'aria era quello che vedevo, consustanziale al suo volto ogni giorno della sua lunga vita. Forse l'aria è qualcosa di morale che riflette nel volto i valori attraversati dalla persona nella sua esistenza.
Barthes infine si accinge a concludere le sue riflessioni sulla fotografia parlando della pietà e della forza vitale delle immagini. Da una parte la pietà, il sentimento di pietà verso alcune immagini fotografiche che aveva visto nella sua vita e che gli avevano fatto punto, coinvolgimento.
“Entravo follemente nello spettacolo, nello spectrum dell'immagine fotografica così come Nietzsche il 3 gennaio 1889 abbracciava piangendo il collo di un cavallo martoriato in un assoluto sentimento di pietà che lo rendeva sempre più folle”
Dall'altra parte Barthes accenna alla forza delle immagini che nella nostra società contemporanea sono molto più vive delle stesse persone.
Le società avanzate tecnologicamente consumano immagini e non più credenze per cui sono sistemi sociali più snelli e leggeri ma anche meno autentici, in definitiva più falsi. Il problema però non è quello di tornare a società ideologiche e fanatiche ma quello di non farsi accumulare nell'immaginario collettivo che certamente l'orgia di immagini può produrre. Se andate in un locale porno di New York, Barthes ne parla nel 1980 ma la cosa vale ancora oggi, voi non troverete il vizio ma l'immagine stereotipata del vizio, per esempio qualcuno che si fa frustare e umiliare. Non necessariamente tale scena implica il vizio nelle sue corde più intime, implica l'immagine e la sua rappresentazione ma il vero vizio è probabilmente da tutt’altra parte. L'immagine illustra, illustra il mondo umano dei conflitti eliminando però il fattore umano, scomposto, balordo del conflitto. L'immagine illustrandolo ne dà una versione recitativa. E infine per Barthes le due dimensioni della fotografia per chi la osserva sono o l'immersione totale nell'immagine stampata che viene vissuta in una sorta di follia soggettiva che giunge a rappresentare una forma di estasi fotografica o mantenendo con l'immagine osservata un distacco di natura estetica e documentaristica.
Dott. Giovanni Castaldi